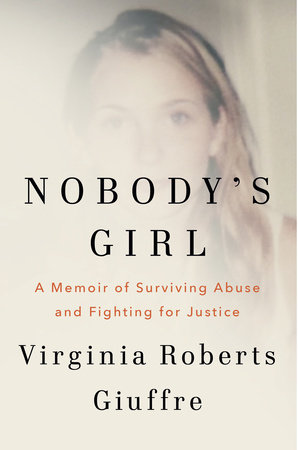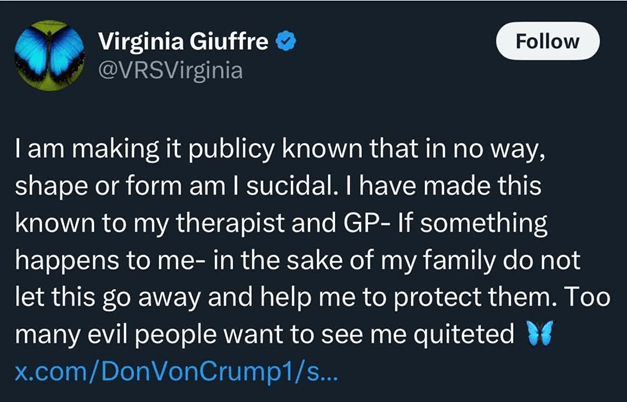Nel cuore di una crisi umanitaria senza precedenti, Israele lancia una controffensiva mediatica che trasforma la tragedia in palcoscenico.
Non più solo bombe e tank: oggi la guerra si combatte con selfie, filtri Instagram e frame accuratamente selezionati. Ed è proprio sui social che si gioca una battaglia invisibile, ma altrettanto letale: quella per plasmare la percezione collettiva, falsificare la realtà e monopolizzare la narrazione dominante.
Il governo israeliano ha permesso a dieci influencer americani e israeliani di entrare brevemente nella Striscia di Gaza nell’ambito di una campagna per “rivelare la verità” sulle condizioni umanitarie dei palestinesi, mentre cresce l’indignazione internazionale per la carestia e i morti. Come raccontato da Haaretz, il tour organizzato dal ministero israeliano per gli Affari della Diaspora è stato un raro caso in cui ai civili è stato permesso di entrare a Gaza. L’iniziativa è stata presentata come una dimostrazione del “meccanismo di distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza” per “confutare le menzogne” di Hamas “diffuse dai media stranieri”, si legge in una nota del ministero.
Non è la prima volta. Dopo lo shock globale provocato dalla foto di Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq, bambino palestinese di un anno e mezzo ridotto a scheletro, il governo israeliano aveva arruolato alcuni influencer e starlette del web accuratamente selezionati per raccontare, a favore di camera, la “verità” ufficiale: non c’è carestia, il cibo c’è, la colpa è dell’ONU. Una narrazione chirurgica, studiata al dettaglio come una campagna marketing, volta a rovesciare la realtà, insinuare il dubbio e neutralizzare la crescente indignazione internazionale.
Nel nuovo paradigma bellico, le guerre non si combattono soltanto con le armi. Il fronte più pericoloso è quello che si insinua nelle menti: la guerra cognitiva, in cui l’arma più potente è la manipolazione dell’opinione pubblica. Israele l’ha capito da tempo e ha strutturato un sistema comunicativo aggressivo, coordinato a livello statale, che sfrutta influencer e opinion maker per rilanciare la narrazione sionista e screditare le testimonianze dal campo o per boicottare le voci divergenti e “pericolose”, come Francesca Albanese, rea di aver curato il dossier ONU che svela “l’economia del genocidio” e stila i nomi delle aziende che fiancheggiano Israele.
Mentre medici e paramedici raccontano l’agonia quotidiana dei bambini palestinesi senza cibo, senza acqua, senza cure e mentre le agenzie umanitarie parlano di fame sistemica e “carestia indotta dall’uomo”, Israele risponde con la retorica dell’efficienza e dell’ordine: gli aiuti ci sono, sono gli altri che falliscono, lasciando intendere che l’ONU spalleggi Hamas. La guerra, dunque, non si gioca solo a Rafah, ma anche su Instagram, X e TikTok. È qui che Israele sta costruendo il suo fronte mediatico, arruolando volti noti per esaltare il “diritto alla difesa” e occultare sistematicamente la realtà delle vittime civili palestinesi.
Si tratta di un’operazione di comunicazione pianificata, una strategia di contro-framing architettata da spin doctor e da esperti di crisi.
Già dopo l’attacco del 7 ottobre, lo Stato israeliano aveva istituito task force digitali per monitorare, manipolare e indirizzare i contenuti online, in modo da raccontare la guerra, “a beneficio della difesa israeliana”. Il Ministro degli Esteri Eli Cohen è stato chiaro: “I social network e l’influenza sull’opinione pubblica internazionale sono fondamentali durante la guerra, al fine di mobilitare il sostegno internazionale”. Cohen ha ringraziato pubblicamente gli influencer “per il loro grande contributo” e li ha definiti “veri patrioti” che “si prendono cura di tutti i cittadini di Israele”. Volti come Noa Tishby (attrice e autrice del libro Israel: A Simple Guide to the Most Misunderstood Country on Earth), Emily Schrader (giornalista con 80 mila follower), Nataly Dadon (modella da 825 mila follower) o Fleur Hassan-Nahoum (già vicesindaca di Gerusalemme e attiva nei rapporti Israele-Emirati) sono solo alcune delle figure chiave nella strategia di “hasbara” – termine ebraico che indica la propaganda ufficiale israeliana.
È un ribaltamento radicale della realtà, tipico delle guerre psicologiche. L’obiettivo non è solo confondere, ma neutralizzare il dissenso, svilire il sentimento umanitario e creare una realtà parallela, dove Israele appare come vittima e salvatore, mentre le organizzazioni internazionali – e le stesse vittime palestinesi – vengono trasformate in complici o bugiardi.
L’uso sistematico degli influencer da parte di Israele per manipolare la narrazione della guerra non è un fenomeno isolato: è parte di una strategia globale per criminalizzare ogni opposizione e legittimare una repressione brutale.
L’informazione è diventata territorio di guerra, il like un’arma politica, l’algoritmo un campo minato. In questo scenario, credere ai video patinati degli influencer schierati da Tel Aviv, mentre Gaza brucia, è come credere ai manifesti pubblicitari durante un bombardamento: una forma di cecità indotta, anestetizzata e pericolosamente complice.